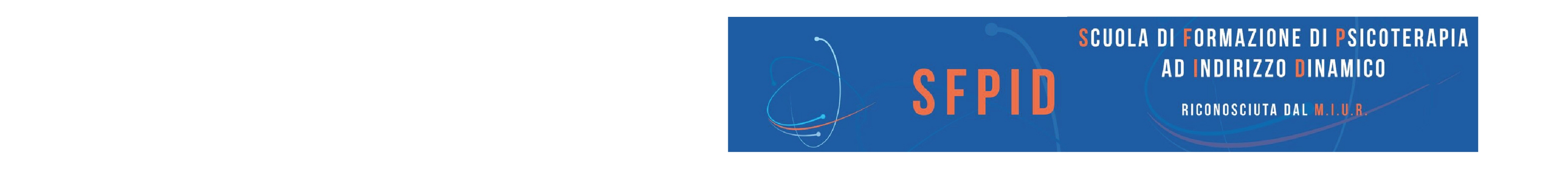Pubblicato su Lo SciacquaLingua
La lingua italiana, come tutte le lingue vive, è in continua evoluzione. Alcuni termini si consolidano nel lessico comune, mentre altri restano confinati in contesti specifici o tecnici. Un esempio interessante di questa dinamica è il confronto tra i termini “peggioramento”, attestato nei vocabolari, e “maggioramento”, non lemmatizzato nei dizionari. Eppure i lemmi in oggetto sono entrambi sostantivi deverbali. Perché, dunque, peggioramento sì e ‘maggioramento’ no?
Il sostantivo “peggioramento” deriva dal verbo “peggiorare” e indica il processo di ‘diventare peggiore’ o di ‘degradarsi’. Questo termine è ampiamente accettato e impiegato nella lingua italiana, trovando applicazione in una vasta gamma di contesti, dalla descrizione di condizioni meteorologiche avverse (“peggioramento del tempo”) alla diagnosi medica (“peggioramento delle condizioni di salute del paziente”).
Il “peggioramento” si può riferire a qualsivoglia situazione in cui vi è una diminuzione della qualità (o quantità) delle prestazioni o delle condizioni. In ambito economico, per esempio, si può parlare di “peggioramento della situazione economica” per designare un deterioramento delle condizioni finanziarie di un Paese o di un’azienda. Così in ambito scolastico: un “peggioramento del rendimento” di uno studente.
Il termine “maggioramento” (che si può far derivare dal verbo “maggiorare”), viceversa, non è così comune e ignorato dai principali vocabolari della lingua italiana che al suo posto lemmatizzano “maggiorazione”. “Maggioramento”, tuttavia, si trova in alcune pubblicazioni (tra cui la “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), soprattutto in contesti tecnici, giuridici o settoriali, per indicare ‘l’atto di aumentare qualcosa’.
Nonostante non sia riconosciuto ufficialmente, l’uso di “maggioramento” – secondo chi scrive – può essere ritenuto corretto in specifici contesti dove è importante sottolineare l’aspetto dell’aumento piuttosto che del miglioramento.
In ambito edilizio, per esempio, si potrebbe parlare di “maggioramento delle superfici edificabili” per indicare un aumento delle aree destinate alla costruzione. In ambito economico, “maggioramento delle risorse finanziarie” potrebbe riferirsi a un incremento dei fondi disponibili per un progetto o un’azienda.
Per chi scrive, insomma, “maggioramento” potrebbe assurgere agli onori dei vocabolari: “Il maggioramento delle aliquote fiscali è stato approvato dal consiglio comunale.” Perché?. Perché – come si sa – l’evoluzione linguistica porta spesso alla creazione di nuovi vocaboli o all’adozione di parole esistenti in nuovi contesti. Ben venga, dunque, ‘maggioramento’.
A cura di Fausto Raso
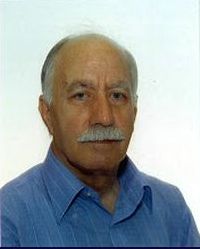
Giornalista pubblicista, laureato in “Scienze della comunicazione” e specializzato in “Editoria e giornalismo” L’argomento della tesi è stato: “Problemi e dubbi grammaticali in testi del giornalismo multimediale contemporaneo”). Titolare della rubrica di lingua del “Giornale d’Italia” dal 1990 al 2002. Collabora con varie testate tra cui il periodico romano “Città mese” di cui è anche garante del lettore. Ha scritto, con Carlo Picozza, giornalista di “Repubblica”, il libro “Errori e Orrori. Per non essere piantati in Nasso dall’italiano”, con la presentazione di Lorenzo Del Boca, già presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, con la prefazione di Curzio Maltese, editorialista di “Repubblica” e con le illustrazioni di Massimo Bucchi, vignettista di “Repubblica”. Editore Gangemi – Roma.